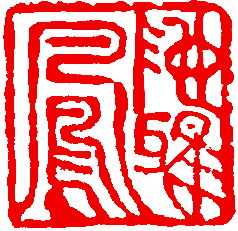Tre Apsara si stagliano davanti alla porta del tempio, un invito al dialogo parlando con le mani.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, con pollice, indice e medio uniti, anulare e mignolo distesi, che sorregge il fiore d’oro chiamato Phka Meas. Alcune mani si aprono nel gesto chiamato Pataka, con la mano tesa e il palmo disteso. Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che ciò che è fragile può essere custodito nel passaggio, senza essere trattenuto.
Nel mito indiano del Samudra Manthan nasce la leggenda delle Apsara, durante il rimescolamento cosmico del Mare di Latte operato dalle Divinità, emersero dalla schiuma sessanta milioni di Ninfe Celesti, portando con sé grazia e bellezza. Il loro nome, dal sanscrito, significa colei che si muove nelle acque. Queste danzatrici sono da sempre legate all’acqua e alla fertilità della terra.
Un famoso bassorilievo di Angkor Wat racconta il loro mito. Sulle pietre dei templi khmer si incontrano due epoche: l’Induismo, dove le Apsara sono ninfe celesti, e il Buddhismo, in cui assumono la forma di Devata. In India, le danzatrici dei templi erano chiamate Deva-Dasi o Yogini.
Queste figure si ritrovano in tutta l’Asia con nomi diversi. In Cambogia vengono chiamate Tep Apsar, in Estremo Oriente e Indocina furono integrate nell’iconografia buddhista attraverso un sincretismo culturale, riconosciute come Devata o Tennin nel Buddhismo giapponese. A Giava, nei templi di Borobudur, Mendut, Prambanan e Penataran, compaiono figure simili chiamate Bidadari, Hapsari o Widodari.
Intorno al 1600, le danzatrici entrarono nelle danze di corte, portando con sé la loro origine sacra come ninfe del paradiso di Indra. La danza, concepita come pratica rituale, divenne parte integrante dei riti regali, necessari per garantire prosperità e benessere. Il repertorio sacro si basa sul Reamker, la versione khmer del Ramayana, e si fonde con il teatro e la musica tradizionale, accompagnata dall’orchestra Pin Peat.
La danza delle Apsara, chiamata in khmer Robam Apsara, è celebre per grazia, delicatezza e armonia. I movimenti delle mani, detti Kbach Boran, formano un linguaggio gestuale codificato che comunica emozioni, racconta storie, trasmette devozione. Si tratta di una vera grammatica del corpo, tramandata oralmente da generazioni, composta da oltre mille forme fondamentali e migliaia di variazioni,
Un famoso bassorilievo di Angkor Wat racconta il loro mito. Sulle pietre dei templi khmer si incontrano due epoche: l’Induismo, dove le Apsara sono ninfe celesti, e il Buddhismo, in cui assumono la forma di Devata. In India, le danzatrici dei templi erano chiamate Deva-Dasi o Yogini.
Queste figure si ritrovano in tutta l’Asia con nomi diversi. In Cambogia vengono chiamate Tep Apsar, in Estremo Oriente e Indocina furono integrate nell’iconografia buddhista attraverso un sincretismo culturale, riconosciute come Devata o Tennin nel Buddhismo giapponese. A Giava, nei templi di Borobudur, Mendut, Prambanan e Penataran, compaiono figure simili chiamate Bidadari, Hapsari o Widodari.
Intorno al 1600, le danzatrici entrarono nelle danze di corte, portando con sé la loro origine sacra come ninfe del paradiso di Indra. La danza, concepita come pratica rituale, divenne parte integrante dei riti regali, necessari per garantire prosperità e benessere. Il repertorio sacro si basa sul Reamker, la versione khmer del Ramayana, e si fonde con il teatro e la musica tradizionale, accompagnata dall’orchestra Pin Peat.
La danza delle Apsara, chiamata in khmer Robam Apsara, è celebre per grazia, delicatezza e armonia. I movimenti delle mani, detti Kbach Boran, formano un linguaggio gestuale codificato che comunica emozioni, racconta storie, trasmette devozione. Si tratta di una vera grammatica del corpo, tramandata oralmente da generazioni, composta da oltre mille forme fondamentali e migliaia di variazioni,
capaci di dare vita a gesti rituali e sequenze narrative.
Questi Kbach si suddividono in famiglie, le Kbach chen, così chiamati i gesti delle dita, Kbach kdam sono i gesti delle mani e Kbach chheu i gesti delle braccia.Attraverso le loro combinazioni, le danzatrici costruiscono un racconto fatto di eleganza e silenzio, un linguaggio non verbale
Questi Kbach si suddividono in famiglie, le Kbach chen, così chiamati i gesti delle dita, Kbach kdam sono i gesti delle mani e Kbach chheu i gesti delle braccia.Attraverso le loro combinazioni, le danzatrici costruiscono un racconto fatto di eleganza e silenzio, un linguaggio non verbale
che si muove tra terra e cielo.
Le danzatrici appaiono leggere, aggraziate, immerse in una danza ispirata dalle Divinità protettrici delle arti. Il volto rimane immobile, per non distrarre dalla perfezione del gesto. Diversamente dalla danza balinese, più spigolosa e vivace, la danza khmer si distingue per fluidità, controllo e raccoglimento, un’eleganza silenziosa che non cattura, ma incanta, come se ogni movimento fosse eco di un’offerta celeste.
Durante la dittatura dei Khmer Rossi, tra il 1975 e il 1979, tutte le forme d’arte furono proibite. Si stima che il 90% degli artisti fu ucciso. Solo negli ultimi decenni la danza è stata riscoperta, ma il peso della perdita culturale è ancora forte.
Oggi, il Balletto Reale della Cambogia, che include la Robam Apsara, è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Insieme ai templi di Angkor, simboli scolpiti nella pietra, questa tradizione vivente continua a ispirare e affascinare il mondo, un ponte tra passato e presente, tra gesto e memoria, tra sacro e umano.
Ma non solo la Robam Tep Apsara cambogiana narra di loro. A Bali, in Indonesia, vive la danza Sanghyang Dedari, dove Dedari deriva da Bidadari, figura affine alle ninfe. È una danza di perfetto sincretismo tra Induismo e culto dei Deva. Le giovani danzatrici entrano in trance, accogliendo spiriti protettivi. È una danza Sacra, non spettacolare, destinata a mantenere l’equilibrio tra il mondo umano e quello invisibile.
In India, le danze classiche come Odissi, Bharatanatyam, Mohiniyattam e Kuchipudi conservano nei templi il gesto divino. Le danzatrici sono donne consacrate che danzano per le Divinità, ma anche per incarnare la bellezza cosmica. Odissi, in particolare, con le sue curve e i suoi ritmi, richiama i movimenti scolpiti delle Apsara nel Tempio del Sole di Konark e nei templi di Lingaraj e Mukteswar, a Bhubaneswar.
Ancora oggi, le danze che evocano le Apsara sono frammenti di sacro che si muovono tra cielo e terra. Danzano nei templi, nei cortili sacri, negli spazi rituali. Alcune sono tramandate da secoli, altre si sono trasformate con il tempo. Ma tutte portano con sé la grazia delle Creature Celestiali.
In questi luoghi, la danza è ancora oggi un atto sacro, una memoria vivente che nasce dal gesto e si trasmette come preghiera.
Le danzatrici appaiono leggere, aggraziate, immerse in una danza ispirata dalle Divinità protettrici delle arti. Il volto rimane immobile, per non distrarre dalla perfezione del gesto. Diversamente dalla danza balinese, più spigolosa e vivace, la danza khmer si distingue per fluidità, controllo e raccoglimento, un’eleganza silenziosa che non cattura, ma incanta, come se ogni movimento fosse eco di un’offerta celeste.
Durante la dittatura dei Khmer Rossi, tra il 1975 e il 1979, tutte le forme d’arte furono proibite. Si stima che il 90% degli artisti fu ucciso. Solo negli ultimi decenni la danza è stata riscoperta, ma il peso della perdita culturale è ancora forte.
Oggi, il Balletto Reale della Cambogia, che include la Robam Apsara, è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Insieme ai templi di Angkor, simboli scolpiti nella pietra, questa tradizione vivente continua a ispirare e affascinare il mondo, un ponte tra passato e presente, tra gesto e memoria, tra sacro e umano.
Ma non solo la Robam Tep Apsara cambogiana narra di loro. A Bali, in Indonesia, vive la danza Sanghyang Dedari, dove Dedari deriva da Bidadari, figura affine alle ninfe. È una danza di perfetto sincretismo tra Induismo e culto dei Deva. Le giovani danzatrici entrano in trance, accogliendo spiriti protettivi. È una danza Sacra, non spettacolare, destinata a mantenere l’equilibrio tra il mondo umano e quello invisibile.
In India, le danze classiche come Odissi, Bharatanatyam, Mohiniyattam e Kuchipudi conservano nei templi il gesto divino. Le danzatrici sono donne consacrate che danzano per le Divinità, ma anche per incarnare la bellezza cosmica. Odissi, in particolare, con le sue curve e i suoi ritmi, richiama i movimenti scolpiti delle Apsara nel Tempio del Sole di Konark e nei templi di Lingaraj e Mukteswar, a Bhubaneswar.
Ancora oggi, le danze che evocano le Apsara sono frammenti di sacro che si muovono tra cielo e terra. Danzano nei templi, nei cortili sacri, negli spazi rituali. Alcune sono tramandate da secoli, altre si sono trasformate con il tempo. Ma tutte portano con sé la grazia delle Creature Celestiali.
In questi luoghi, la danza è ancora oggi un atto sacro, una memoria vivente che nasce dal gesto e si trasmette come preghiera.
Riempie il mondo di bellezza.
Vuoi conoscere di più ? Scopri la storia completa delle Apsara, tra mito, danza e spiritualità.
Un approfondimento sulle loro leggende
Salvo diversa indicazione, tutte le fotografie in questa pagina hanno
property e model releases.
Memoria collettiva, passo condiviso, eco di un legame che attraversa il tempo.
Un passo che non tocca terra, un invito leggero, nell’offerta timida di un gesto.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, che sorregge il fiore d’oro. L’altra mano è sollevata nel gesto Pataka, Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che ciò che viene offerto va protetto, ma senza trattenerlo, è un dono che resta leggero, e che può ancora trasformarsi.
Dita unite, il fianco trattiene quel vuoto prima di fiorire.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, che sorregge il fiore d’oro. Alcune mani si aprono nel gesto chiamato Pataka. Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che ciò che è fragile va preservato nel passaggio, senza forzarne il compimento.
Per la bellezza che verrà la gioia si trasforma in danza.
Disegnano il tempo le mani, una il seme teso, l’altra la luce spiegata come fosse già il tempo passato.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, che sorregge il fiore d’oro. La mano opposta si apre nel gesto chiamato Pataka. Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che ciò che viene offerto esiste già nella memoria, e il gesto lo trattiene come soglia tra ciò che è stato e ciò che non torna.
Le mani sembrano dire che, il tempo porterà a una nuova vita , ma il tempo è tiranno.
Nota descrittiva
Katakaamukha Kbach per custodire ciò che è fragile. Pataka come gesto complementare di protezione. Il piede poggiato e lo sguardo sospeso generano una tensione tra presenza e attesa. Il gesto evoca possibilità, senza affermarla: il tempo resta non dominato.
Ciò che è stato resta nei gesti scolpiti, ancoradanza per chi non ancora non torna.
Custodiscono una vita che non è mai stata e invocano una a venire, le mani.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, che sorregge il fiore d’oro. Alcune mani si aprono nel gesto chiamato Pataka.Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che ciò che deve ancora accadere viene chiamato con fermezza, senza aspettare il tempo.
Celeste attesa di chi verrà, ma non invana.
La roccia è diventata vita, sbocciando dalla memoria dei tempi.
Un invito silenzioso a guardare. Noi siamo da sempre qui.
È il tempo che si piega, per ascoltare.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Katakaamukha Kbach, che sorregge il fiore d’oro. Le braccia si aprono nel gesto chiamato Pataka. Il significato della danza in questo contesto, sembra dire che l’offerta si raccoglie in ascolto, e il gesto attende ciò che ancora non è stato pronunciato.
Il muro le ha trattenute per chi sa guardare.
Che risorga, non è un desiderio. È il cielo che lo pretende, il gesto lo trattiene, il fiore d’oro lo custodisce.
Nota descrittiva
Katakaamukha Kbach collettivo su tre apsara. Il fiore d’oro è tenuto come custodia di memoria. Il gesto non invoca, ma trattiene ciò che deve risorgere. Il corpo afferma la funzione rituale, il fiore agisce come segno sacro.
Custode del passato, la Devata scolpita nella pietra, eco di un tempo remoto.
Concentrata sul gesto, lo attende fiorire, Angkor.
Non si fa raggiungere dal tempo , danzando.
Nota descrittiva
Katakaamukha Kbach non invoca né accompagna. Il corpo, pur in movimento, preserva qualcosa che il paesaggio tenta di riassorbire. Il gesto comunica continuità e resistenza.
In raccolta, due tonalità di attesa, tra gesti che non avanzano e silenzi che custodiscono.
Nota descrittiva
Due varianti del gesto in attesa. La prima figura comunica una sospensione fragile, con Katakaamukha Kbach che raccoglie senza aprire il corpo. La seconda, più composta, nel gesto chiamato Pataka. Per tutte e due le fotografie, questo contesto, sembra che la gestulità sembri dire che il passaggio viene custodito, ma non compiuto.
Le custodi silenziose di un passato che torna.
Speranza per Angkor, il richiamo del gesto che parla danzando.
A riempir Angkor di danza, la speranza congiunta ringrazia.
Nota descrittiva
Si vede il gesto del Kbach Sampeah, solitamente usato per salutare. In questo caso, viene impiegato per accogliere il futuro, ringraziando ciò che è in arrivo.
Ogni figura è una pausa del tempo,ogni silenzio, una promessa.
Ringraziamento condiviso davanti al silenzio che ascolta.
Nota descrittiva
In questa foto si vedono le tre Apsara che tengono il fiore d'oro , mentre gaurdano il Tempio Theravāda.In questo contesto il gesto delle tre danzatrici, sembra dire che il gesto raccoglie ciò che è stato sognato e lo consegna al silenzio, come forma di ringraziamento condiviso.
ll sogno è stato consegnato, il gesto raccolto, la memoria riaccesa.Ora la danza torna al
silenzio, ma resta visibile,nel corpo, nella pietra, nello sguardo che continua a immaginare e in voi che avete fatto questo viaggio con me.
Angkor, la città sacra sospesa nel silenzio del tempo
Angkor Wat, grazia tra le pieghe del tempo
Angkor, where the Tewada echo through stone and silence
Angkor, dove i Tewada riecheggiano tra pietra e silenzio
アンコール——石と静寂に響くテワダの声
Angkor, dove i Tewada riecheggiano tra pietra e silenzio
アンコール——石と静寂に響くテワダの声